Delimitazione confine tra Francia e Regno di Sardegna tra il 1860 e il 1861: il racconto dello storico sanremese Gandolfo
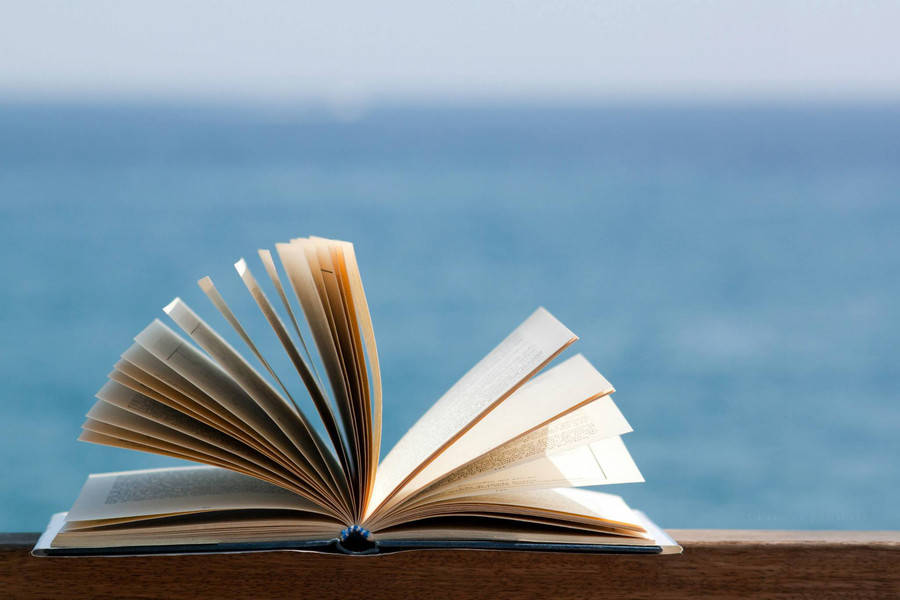
Nuovo appuntamento con la storia locale
Sanremo. Il tradizionale appuntamento con la storia matuziana a cura dello storico Andrea Gandolfo questa settimana è dedicato alla delimitazione del confine tra il Regno di Sardegna e la Francia tra il giugno 1860 e il marzo 1861 nella zona delle Alpi Marittime, all’indomani della cessione del circondario di Nizza alla Francia in virtù del trattato di Torino del 24 marzo 1860. Ecco la storia della delimitazione del confine tra la Francia e il Regno di Sardegna tra il 1860 e il 1861:
“Il 27 giugno 1860 venne concordata la prima determinazione dei confini tra il Regno di Sardegna e la Francia tramite la stipulazione di un protocollo, il cui articolo 3 stabiliva che una commissione, nominata appositamente dai due governi, avrebbe fissato sul luogo i limiti confinari e posizionato i relativi segnali. Il protocollo sanciva inoltre la perdita definitiva per il Piemonte del saliente di Saorgio e dell’alta Valle della Tinea, dove il nuovo confine lasciava in territorio sardo soltanto la parte della vallata a sinistra dell’omonimo torrente. Questa diversa ripartizione venne peraltro caldeggiata dal governo francese che, in sintonia con la volontà espressa dalle popolazioni locali, alla vigilia della firma del protocollo aveva chiesto che il comune di Isola, ubicato appunto sulla sinistra della Valle della Tinea, fosse annesso alla Francia.
La richiesta venne poi ulteriormente sostenuta dai commissari transalpini incaricati di fissare la nuova linea confinaria in una nota trasmessa ai loro colleghi piemontesi fin dal 20 giugno. Il governo sardo riuscì però ad escludere dai territori che avrebbero dovuto essere ceduti alla Francia nel comprensorio delle Alpi Marittime, le famose “terre di caccia” di Vittorio Emanuele II, situate nelle alte valli della Tinea e della Vesubia e rimaste poi italiane fino al 1947. Furono parimenti conservati al Piemonte, nonostante il voto favorevole all’annessione alla Francia espresso dai loro abitanti nel plebiscito del 15-16 aprile 1860, i centri dell’alta Roia Tenda e Briga, destinati peraltro a divenire francesi nel 1947.
Nella zona, tuttavia, il nuovo confine, che estendeva la sovranità francese sull’intera valle del Bevera e tagliava con un cuneo quella della Roia interrompendo il collegamento diretto tra la Liguria e il Basso Piemonte, sarebbe stato foriero di aspre controversie legate soprattutto al transito frontaliero, ai diritti di pascolo e al godimento del diritto di proprietà, che avrebbero obbligato i governi italiano e francese a concludere una serie di convenzioni particolari tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del secolo scorso.
Il 14 luglio era stato intanto emanato il decreto reale n. 4176, conseguente alla legge di ratifica del trattato di cessione di Nizza alla Francia, nonché alla legge n. 4158 dell’8 luglio 1860 relativa al riordino del pubblico servizio nella parte della provincia di Nizza rimasta allo Stato. Tale decreto costituì l’atto di nascita ufficiale della Provincia di Porto Maurizio (che avrebbe poi assunto l’attuale denominazione di Provincia di Imperia nel 1923), formata “provvisoriamente” dai circondari, mandamenti e comuni già facenti parte della Provincia di Nizza e non compresi nel trattato di cessione del 24 marzo 1860, ad eccezione dei comuni del mandamento di Tenda, tra i quali Briga, Tenda e altri centri montani minori, che, in attesa della fissazione definitiva dei confini, venivano nel frattempo aggregati alla provincia di Cuneo.
L’istituzione della nuova provincia non fu peraltro motivata da ragioni di indole politica o legislativa, ma nacque dalla concreta esigenza di distribuire in modo organico e razionale il notevole numero dei comuni rimasti staccati dal capoluogo di Nizza. Il nuovo ente territoriale, caratterizzato dalla presenza di una popolazione accomunata da medesime origini, usanze e dialetti, avrebbe assunto nei decenni successivi la delicata funzione di provincia di frontiera con il dipartimento delle Alpi Marittime.
Quattro giorni dopo la costituzione della provincia di Porto Maurizio, il battaglione della guarnigione sarda di stanza a Monaco, su richiesta del governo francese, lasciò il territorio del Principato, senza tuttavia essere immediatamente rimpiazzato da un omologo contingente transalpino. Nel frattempo, dopo lo svolgimento delle votazioni a Mentone e Roccabruna per l’annessione alla Francia, il principe di Monaco Carlo III aveva ricevuto assicurazioni dal governo di Parigi che tale consultazione era stata soltanto ufficiosa, per cui non avrebbe automaticamente comportato l’annessione delle due cittadine alla Francia. Contrariamente però a quanto dichiarato, il governo francese inviò propri funzionari nei due centri rivieraschi in sostituzione di quelli sardi, avviando in sostanza una fase occupazionale che poteva essere equiparata ad una vera e propria annessione.
Desiderando conservare i suoi feudi, il sovrano monegasco chiese allora alle autorità di occupazione di raggiungere un compromesso sulla questione delle due città contese in cambio dell’accettazione di alcune garanzie, che ponevano di fatto il Principato sotto il protettorato francese e che furono accolte da Napoleone III. Il 2 febbraio 1861 Carlo III cedette quindi alla Francia i suoi diritti su Mentone e Roccabruna dietro un compenso di quattro milioni di franchi, mentre l’imperatore si impegnava da parte sua a costruire una strada carrozzabile da Monaco a Nizza e a far passare nel territorio del Principato il tracciato della linea ferroviaria Genova-Nizza. Il 9 novembre di quattro anni dopo Carlo III stipulò infine con Napoleone un’altra convenzione, che prevedeva la completa inclusione del territorio monegasco nello spazio doganale della Francia, alla quale il Principato sarebbe rimasto legato in base ad una serie di ulteriori accordi politici ed economici stipulati nei decenni successivi tra i due Stati.
Il 23 agosto 1860 era stata intanto firmata a Parigi una convenzione tra il Regno di Sardegna e la Francia al fine di risolvere alcuni problemi sorti in seguito alla cessione delle due province e determinare in spirito di equità la quota di partecipazione dei territori ceduti nel debito pubblico del Piemonte. Nel frattempo i due governi nominarono una nuova commissione per la delimitazione dei rispettivi confini, composta dal luogotenente colonnello Galinier e dal capo squadrone Smet dello Stato Maggiore transalpino per la Francia, e dal luogotenente colonnello Vittorio Federici e dal capitano Agostino Ricci dello Stato Maggiore piemontese per il Regno di Sardegna. Riunitasi a Torino il 5 settembre, la commissione decise, per quanto riguardava la zona del Nizzardo, di stabilirne tutti i relativi limiti frontalieri a partire dal punto in cui il confine si staccava dalla grande cresta delle Alpi sino al mare.
Il protocollo di tali operazioni venne firmato a Nizza il 25 novembre 1860, mentre sei giorni dopo il tenente colonnello Federici trasmise al Ministero degli Esteri sardo una dettagliata relazione in merito all’operato della commissione stessa. Le principali modifiche alla linea confinaria stabilita dal protocollo del 27 giugno riguardarono lo spostamento della frontiera a vantaggio del Piemonte nel vallone di Mollières e a Testa d’Alpe, mentre risultarono a favore della Francia le variazioni apportate nell’alta Valle della Tinea, nel vallone della Tessera e nei pressi di Mentone. In quest’ultimo settore, in particolare, la linea venne fatta retrocedere leggermente verso levante in corrispondenza del corso del torrente San Luigi, come era stato richiesto dai commissari sardi guidati dal tenente colonnello Federici per ragioni di natura prettamente difensiva.
L’attività svolta dai due commissari sardi ottenne il pieno assenso del governo presieduto da Cavour, che affidò a Federici e Ricci l’incarico di trattare le pratiche relative alla determinazione dell’esercizio dei diritti di proprietà dei cittadini residenti sui due versanti della frontiera ed altre questioni di carattere doganale, poi regolate da un protocollo firmato il 16 febbraio 1861. D’intesa tra i due governi, venne stipulata un’ulteriore convenzione il 7 marzo 1861 tra il ministro degli Esteri sardo Carutti di Cantogno e l’incaricato d’affari francese nella capitale sabauda Aloys de Rayneval. Il 1° settembre si riunì quindi la commissione internazionale incaricata del posizionamento dei nuovi termini confinari tra la Francia e il Regno d’Italia nella regione compresa tra il mare e il Monte Enciastraia.
Nel corso delle operazioni di delimitazione, coordinate dai commissari italiani Federici e Ricci e dai loro colleghi francesi Smet e Holot, vennero collocati 39 termini numerati da 77 a 114, come attestato nel relativo processo verbale steso a Torino il 29 ottobre 1861. Questa delimitazione confinaria, che riproduceva praticamente senza varianti quella fissata nel protocollo del 25 novembre dell’anno prima, determinò una linea di frontiera tra il Nizzardo e il territorio del Regno d’Italia che sarebbe rimasta sostanzialmente immutata fino allo scoppio del secondo conflitto mondiale. Data la sua notevolissima valenza storica ai fini del tema trattato nel presente saggio, mi pare dunque opportuno riportarne il tracciato completo come viene dettagliatamente citato da Vittorio Adami nella sua opera sul confine italo-francese:
“Dal punto in cui sbocca nel mare il piccolo torrente di San Luigi, tra Ventimiglia e Mentone, il confine italo-francese, seguendo il letto del torrente medesimo, raggiunge la spalla occidentale del ponte detto di San Luigi. Su questo ponte, che rimane così completamente in territorio italiano, passa la strada rotabile del litorale ligure chiamata della Cornice. Un termine di confine portante il numero d’ordine 114 è stabilito sul margine settentrionale della strada presso la spalla occidentale del ponte. Sulla parete di roccia immediatamente ad occidente del ponte è dipinto un grande triangolo, che, unitamente ad altro simile, posto su di un’asta presso la riva del mare, serve ai naviganti per determinare, mediante una visuale, la linea di separazione dei mari territoriali dei due Stati, ed ai pescatori la delimitazione della zona di pesca.
Dal termine 114 la linea di confine non segue più il fondo del torrente San Luigi, ma si dirige in linea retta, con direzione di nord-ovest, alla cima della Girauda, sullo sprone che s’interpone fra le due vallette di San Luigi ad est e di Garavan ad ovest. Segue quindi la linea displuviale di questo sprone e passa sulle cime di Monte Carpano e Castello del Lupo… Per la cresta delle Rocche della Longoira, Passo di Corna e Rocche Campassi raggiunge il Monte Grammondo (m. 1378), importante nodo orografico che s’insinua colle sue diramazioni fra le tortuosità della valle del Bevera ad est e a nord, e contro i valloni di Ciarabaira, di San Romano e dell’Aigue ad ovest.
Dal M. Grammondo proseguendo verso nord-ovest passa sul Bricco Treitore, sul passo omonimo, attraversato dalla strada mulattiera che dalla valle Bevera mette a Sospello e a Castellar, sulla schiena rocciosa di Moutacier e della Serrea, scende al passo di Cuore, attraversato da altra mulattiera che da Bossaré in Val Bevera conduce a Sospello, e per Monte Cuore giunge a Testa di Cuore (m. 1091). Da questo punto scende, con direzione nord, nel vallone del Bevera e lo attraversa per risalire, volgendo ad ovest, sulla cresta del contrafforte interposto fra i valloni di Tron ad est e del Bassera ad ovest. Passa su monte Grazian, Colle di Paola e, giunto all’altezza del colle di Brouis, piega ad est e raggiunge il vallone detto del Rio che segue fino al suo sbocco nel Roia. In tutto il percorso sin ora descritto il confine politico coincide, salvo per brevi tratti, con gli antichi limiti amministrativi dei circondari di Nizza e di San Remo.
Dallo sbocco nel Roia del vallone del Rio fino allo sbocco del Vallone delle Pasque, il confine è costituito dal Roia stesso; risale quindi il burrone delle Pasque sino all’incontro della strada mulattiera che da Libri conduce a Breglio… Di qui, seguendo l’andamento tortuoso dell’antico confine amministrativo dei due comuni di Breglio e Piena, per l’altura Damasco raggiunge il ramo settentrionale del Vallone dell’Amore… Volgendo quindi verso nord si porta al Passo della Croce di Mailisa, scende poscia pel vallone di Ciapela Valgrana sino alla sua confluenza in quello di Carlava e, risalendo questo e quello di Crauzel, arriva al Passo dell’Arpetta, alla punta dell’Arpetta (m. 1612) e alla Punta Comune… Dalla punta Comune il confine segue il limite amministrativo tra Saorgio e Briga, passa sulla Cima Peigarole, quindi per le Rocce Campane, Passo della Volpe, raggiunge il vallone di Casa Giovanna che accompagna fino al suo sbocco nel vallone del Bendola che risale fino alla Bassa di Giacque. Da questo punto segue il letto del torrente Groa dalle origini al suo sbocco nel fiume Roia…
Il confine ritorna così al fiume Roia dopo fatto un percorso di circa 24 chilometri, in proiezione orizzontale, sulla sinistra della valle. Il tratto del fiume Roia incluso nel confine francese è di 15 chilometri circa… [Dallo] sbocco del torrente Paganin… il confine prende la direzione generale di est-ovest e segue l’antica divisione amministrativa fra i comuni di Tenda e Saorgio. Risale il vallone Paganin e per le Rocche dei Corvi raggiunge, alla Cima Gaurone (m. 1621), la cresta del contrafforte interno che forma la cintura meridionale del bacino di Valle Miniera, e che ha origine alla Cima del Diavolo sulla catena del monte Clapier.
Dalla Cima Gaurone scende quindi al Passo Gaurone (m. 1586), sale alla Cima della Nauca (m. 2207), attraversa il Passo del Taupé o Colla di Vespé, tocca il M. Bocche Rosse (m. 2441), il M. Scandai[l] (m. 2370), il M. Macruera (m. 2522) ed a Cima del Diavolo (m. 2687) raggiunge il grande contrafforte di M. Clapier, che, interponendosi fra le valli del Roia, della Vesubia e del Varo, si spinge verso sud diramando, come un enorme polipo, i suoi montuosi tentacoli sulla costa tra Ventimiglia e Nizza. Dalla Cima del Diavolo il confine passa verso sud alla Cima Capelet e quindi, volgendo ad ovest per la costa di Cafalch e per il Vallone della Festouletta, scende in Valle Gordolasca, affluente del Vesubia… Il confine scende per il letto del Gordolasca per circa 900 metri e cioè fino alla confluenza del rio Valletta… volgendo nuovamente ad occidente, risale questo rio e raggiunge la Cima della Valletta…
Alla Cima della Valletta il confine si è portato sulla cresta del contrafforte che chiude a mezzodì il Vallone di Madonna delle Finestre e si mantiene su di esso toccando la Cima di Pertù di Prals, la Testa del Cinant (m. 2356), il Monte Lapassè, il M. Clapeiretta, la Cima di Founs Freja (m. 2334) e la Testa della Baissa del Mare… Di qui volge a nord-ovest e seguendo il rio chiamato Gorgia del mare Sottan scende in fondo alla valle della Madonna delle Finestre…
Per il breve tratto di un centinaio di metri a monte, e cioè fino allo sbocco del Vallone delle Madame, il confine segue il corso del Rio Madonna delle Finestre… Da questo punto il confine risale il rio delle Madame e si porta sulla cresta del contrafforte che separa i due valloni di Madonna delle Finestre e di Boreone… Di qui scende direttamente sul Rio Boreone… Volgendo a sud-ovest il letto del Boreone forma poscia confine sino allo sbocco del vallone di Arcios… Per il fondo di quest’ultimo vallone il confine con direzione di nord-ovest sale al Balaur Saubran nel quale si toccano i limiti dei tre comuni di Valdieri, Valdiblora e San Martino di Vesubia… Piega poscia ad angolo retto in direzione di sud-est; passa il Balaur Soutan e scende nel rio della Valletta, nel punto in cui il vallone des Amberts incontra i limiti dei due comuni di Valdiblora e di San Martino di Lantosca…
Con direzione di sud-ovest il confine sale sul contrafforte che s’interpone fra Vesubia e Tinea, e, raggiunta la displuviale alla Bassa della Balma della Frema… sale su quest’ultima cima (m. 2243)… Dal Baus della Frema esso corre in linea retta al Monte Raja che trovasi ad ovest dell’intermedio vallone di Bramafame… Dal Monte Raja, volgendo ad ovest, scende nel vallone del Gasch che accompagna fino alla sua confluenza con quello di Cabana Vegia… Il letto di quest’ultimo vallone forma quindi confine sino quasi alle sue origini sotto la Cima Girauda o di Giraud (m. 2606)… Dal Clout di Malaunet il confine segue la linea displuviale dello sprone montuoso che va a cadere con direzione nord-ovest nel punto dove il Vallone di Mol[l]ières sbocca nel Tinea… Da questo punto fino alla confluenza del vallone di Buena Neuce il confine si mantiene nel letto del Tinea, risale quindi quel vallone sino all’incontro del vallone del Pusè e, volgendo con quest’ultimo a nord-ovest, raggiunge un colle che separa due cime: il Monte Cialan (m. 1918) ad est e la testa di Bellarout ad ovest…
Da qui scende, per la cresta rocciosa detta di Vial, alla confluenza dei due valloni di Castiglione e della Guercia… Sale quindi con direzione di nord-ovest per le Serre del Terrassier alla Serriera del Camp… Volge quindi ad ovest, ed in linea retta si porta al Cloutas… Dal Cloutas piega verso nord quasi ad angolo retto, taglia… la strada mulattiera che da S. Stefano per Colla Lunga conduce a Vinadio e raggiunge la Cima di Colla Lunga dove finalmente si stabilisce sulla displuviale alpina… Dalla Cima di Colla Lunga scende il confine al Colle Barbacana… e quindi, mantenendosi sempre sulla linea displuviale, passa per Cima di Malaterra (m. 2838), Cima di Corborant (m. 3011), Passo dell’Ischiatore (m. 2860), Becco Alto dell’Ischiatore (m. 3000), M. Timbras (m. 3031), Cima Blancias (m. 2951), e i Colli del Ferro (m. 2550) e del Pouriac… Sale quindi alla Cima del M. Enciastraia dove ha termine la sezione del confine corrispondente al Nizzardo”. Gli accordi del 7 marzo comprendevano anche una serie di clausole di natura economica destinate a regolamentare i diritti di scambio ed esenzione doganale per quegli abitanti delle zone di confine possessori di beni che erano rimasti parte in territorio italiano e parte in quello francese.
In particolare, venne stabilito di concedere l’autorizzazione ai produttori italiani e francesi di introdurre liberamente nei rispettivi Stati, entro un raggio di cinque chilometri dalla frontiera, derrate agricole, legna, concimi, sementi e vari generi alimentari (tra i quali latte, burro e formaggio), senza corrisponderne le relative imposte doganali. Analoga esenzione fu accordata anche per le greggi portate al pascolo e le piante tagliate nei boschi. Grazie a queste clausole, nel volgere di pochi anni Tenda e Briga divennero due tra i più fiorenti comuni d’Italia, mentre l’alta Roia cominciava ad essere percorsa da un intenso traffico destinato soprattutto al mercato di Nizza. Di fatto, la zona franca che ne scaturì rappresentò un potentissimo volano per l’economia di molti comuni italiani e francesi del comprensorio delle Alpi Marittime, dove peraltro si registrò anche – come logica conseguenza del regime di franchigia doganale – un notevole incremento delle attività illecite legate al fenomeno del contrabbando.

 0
0
